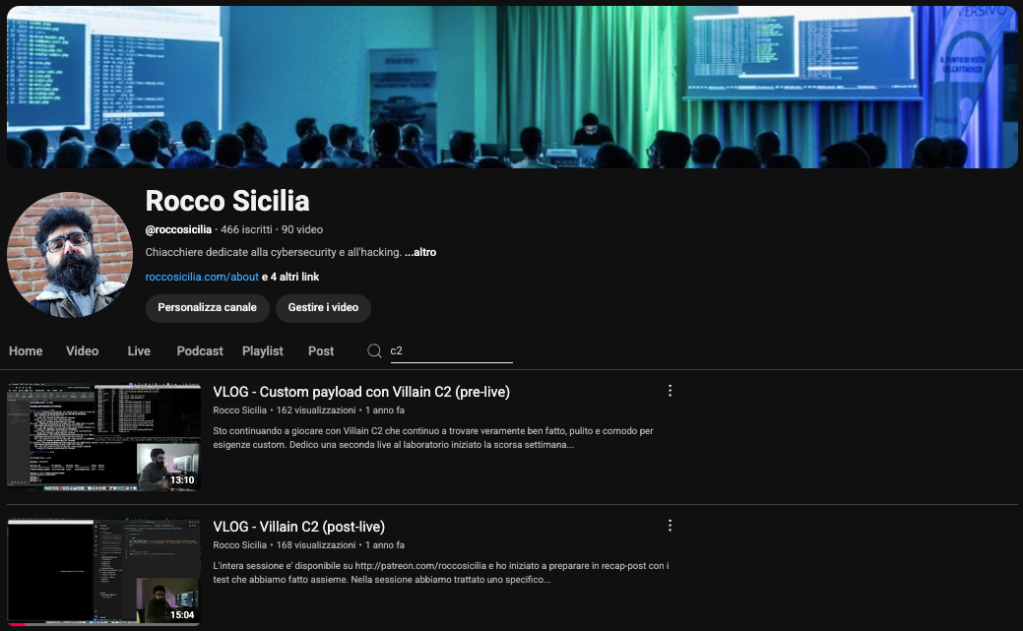
文章讨论了企业在遭受网络攻击后如何有效恢复系统的挑战。作者指出,许多IT管理者缺乏基本的恢复程序,在无法从备份中完全恢复时面临困难。文章强调了不可变存储的优势及其在防止数据篡改中的作用。然而,在真实攻击中,攻击者可能建立持久性后门,导致数据被加密或破坏。作者建议企业需要详细的日志和检测系统来追踪攻击者的活动,并找到合适的恢复点。此外,作者提出了几种应对策略,包括使用黄金镜像重建系统、分阶段恢复数据以及在受控环境中验证系统完整性。这些方法虽然可行,但需要企业在平时做好准备和投资。 2025-6-27 14:47:24 Author: roccosicilia.com(查看原文) 阅读量:9 收藏
Premessa: non è un tema piacevole ed il motivo è abbastanza scontato. Pochissimi IT manager / CIO / CISO hanno seriamente affrontato il task per portarsi a casa una procedura di base (scritta, nero su bianco e adottabile “adesso”) di ricostruzione dei sistemi a seguito di un incidente che non consente una recovery completa da backup.
Qualche tempo fa ho discusso il tema con Mattia Parise in uno di quegli scambi sempre utili per ragionare su un tema considerando diversi punti di vista. Da quella chiacchierata sono nate un po’ di riflessioni.
Giustamente ci si potrebbe chiedere:
“In quale occasione dovrei trovarmi a non poter eseguire una recovery da backup? Uso storage immutabili da anni.”
Lo storage immutabile, cosa molto utile ovviamente, ha una funzione precisa: impedisce che un dato archiviato sia compromesso. Quindi, fino a scadenza e fino a quando lo storage funziona, il dato che andiamo ad archiviare in questi sistemi è inalterabile. Il vantaggio è evidente: nessuna modifica possibile significa anche nessuna compromissione da cripto-malware.
Dobbiamo però sempre fare i conti con quello che accade nel mondo vero, durante un attacco vero. Chi ha adottato da qualche tempo tecnologie di detection serie e si è andato a vedere cosa individuano i vadi EDR/XDR/SIEM, avrà probabilmente notato che gli attaccanti tentano di ottenere un accesso ai sistemi compromettendo una credenziale o un sistema all’interno della rete. In questo processo una delle fasi fondamentali è la persistenza: l’attaccante fa in modo di modificare uno o più sistemi in modo da garantirsi una “backdoor” (uso questo vecchio termine anche le il modello attuale è un po’ differente) sempre attiva all’interno della rete.
Ne avevo parlato in un paio di vecchi video:

Il problema da considerare è che dalla compromissione dei sistemi a livello di persistenza – ovvero il threat actor è dentro e si è garantito un canale di comunicazione stabile – a quando vendono eseguire le azioni che generano impatto sui sistemi (es: cripto-malware) può passare del tempo.
Se mettiamo le fasi di un attacco su una timeline vedremo quindi un momento in cui il threat actor inizia a muoversi nella rete per poi arrivare ad eseguire le azioni di effettivo impatto come la compromissione dei dati di produzione.

Ovviamente non è possibile fare una previsione dei tempi che intercorrono tra l’inizio delle azioni offensive ed il momento in cui iniziano le attività di compromissione dei dati. Diventa quindi estremamente importante ricostruire gli eventi per identificare il metodo di accesso e quando la compromissione iniziale è avvenuta. Comprendere il metodo di accesso ed eseguire le correzioni è necessario per evitare che l’attaccante lo riutilizzi in futuro. Sapere quando è iniziata la compromissione dei sistemi ci server per capire da quale versione degli archivi eseguire la revocery.
Purtroppo capita di non avere informazioni certe a disposizione: meno la struttura è matura dal punto di vista dei sistemi di detection e più è probabile che non ci siano dati, logs, tracce delle azioni del threat actor con l’inevitabile conseguenza di non sapere, con precisione, data e ora della compromissione.
Ci si trova così a non saper rispondere con precisione alla domanda “da quale backup eseguiamo il ripristino?”; restando sulla nostra ipotetica timeline, ripristinare i sistemi di cui si dispongono i backup, utilizzando un recovery point successivo dal 5 maggio compreso equivale a mettere online sistemi che, probabilmente, porteranno online anche il canale di comunicazione che il threat actor ha utilizzato. Conseguenza (vista con i miei occhi più di una volta): tempo qualche giorno e si ricomincia da capo.
Come se ne esce?
Premesso che al tema vorrei dedicare un video con qualche approfondimento, in questa occasione provo ad argomentare un po’ di spunti a livello di prevenzione e gestione.
Prevenzione: se so cosa è successo posso valutare il recovery-point più idoneo
Ovviamente se avessimo la possibilità di sapere, analizzando gli eventi a ritroso, quali azioni ha eseguito il threat actor per compromettere il sistema e garantirsi la permanenza all’interno della rete, il problema sarebbe per lo meno affrontabile: se abbiamo una indicazione temporale precisa abbiamo automaticamente trovato il recovery-point per i sistemi e si potrebbe valutare una restore degli ambienti dagli archivi immediatamente precedenti alla data di compromissione. Ovviamente sto dando per scontato che gli archivi siano disponibili e su supporti immutabili e che non siano stati manomessi in nessun modo.
Considerando che il punto di accesso potrebbe essere un qualsiasi endpoint o asset della rete dovrei avere visione di tutti i logs relativi ad accessi e change di configurazioni dei sistemi. Una parte di questi dati li potremmo avere all’interno della piattaforma EDR/XDR con un livello di dettaglio anche molto alto, ma solitamente la retention di questi dati è bassa. Sui SIEM si adottano retention più profonde ma raramente viene portata tutta la telemetria disponibile sui diversi sistemi di detection anche sul SIEM per un banale problema di spazi e costi di licenza.
In parole povere: disporre dei dati per ricostruire le azioni del threat actor è possibile ma non lo possiamo dare per scontato. Dobbiamo disporre di sistemi di detection che raccolgano le telemetrie utili, dobbiamo raccogliere dati da tutti i dispositivi in rete e dobbiamo disporre di una retention che sia superiore rispetto alla durata dell’attacco. Se tutti questi elementi si incastrano possiamo portarci a casa un risultato.
E se non si incastrano?
Non ho certezza di un recovery-point “pulito”
In questo caso abbiamo un bel problema: i backup ci sono ma non sappiamo di quale fidarci perché non sappiamo quanto tempo prima il threat actor ha manomesso i nostri sistemi. Come ci si garantisce una partenza sicura? Ci sono diverse opzioni ed alcune comportano dei rischi da considerare.
Inevitabilmente è necessario considerare come gestiamo e verifichiamo il processo di backup: ad esempio se disponessimo di una immagine verificata dei sistemi operativi e loro configurazione e di un dataset dei dati critici, il problema sarebbe relativamente aggirabile con un processo di “rebuild” basato sulla gold image ed i dati. In un periodo storico in cui siamo abituati (per indiscussa comodità) a disporre dei soli backup “Full VM” probabilmente pochi/pochissimi oggi potrebbero pensare di far ripartire i sistemi in questo modo. Un’immagine dei sistemi operativi e delle relative applicazioni consentirebbe una rapida re-installazione pulita degli ambienti a cui potrebbe far seguito una recovery dei soli dati. Ovviamente questo richiede una strategia di backup dedicata che vada per lo meno ad affiancare al classico backup “Full VM” anche la creazione e verifica periodica delle immagini di partenza, quindi questa strategia è adottabile se ci si è preparati in anticipo a questa evenienza.
Un’altra opzione è quella di eseguire l’avvio dei sistemi in ambiente controllato al fine di verificare, real time, eventuali anomalie. Anche questo metodo porta con se non poche difficoltà considerando che se siamo arrivati a questo punto significa che i sistemi di detection/protection che abbiamo in uso sono già stati probabilmente aggirati, ha quindi senso dotarsi di sistemi alternativi per assicurarsi che eventuali componenti malevole installate nei sistemi passino inosservate quando le macchine vengono riavviate. In pratica dobbiamo controllare i sistemi uno ad uno non avendo certezze sulla loro integrità. Fattibile? Certo, ma richiede tempo ed infrastrutture da dedicare all’operazione.
Se trovi i miei post interessanti iscrivi ai miei canali YouTube e Patreon. Per rimanere aggiornato segui il blog:
Conclusioni
Per quanto sia fastidioso dobbiamo prepararci ad un piano di emergenza che ci consenta una ripartenza anche nel caso peggiore. Non c’è un unico modo di operare ma non possiamo basarci solo sui paradigmi che abbiamo imparato ad utilizzare nel contesto del classico fault tecnico. Gli incidenti nella sfera della sicurezza informatica aggiungo nuovi elementi che vanno considerati ed il nostro piano di recovery si deve adeguare ad una nuova esigenza.
如有侵权请联系:admin#unsafe.sh